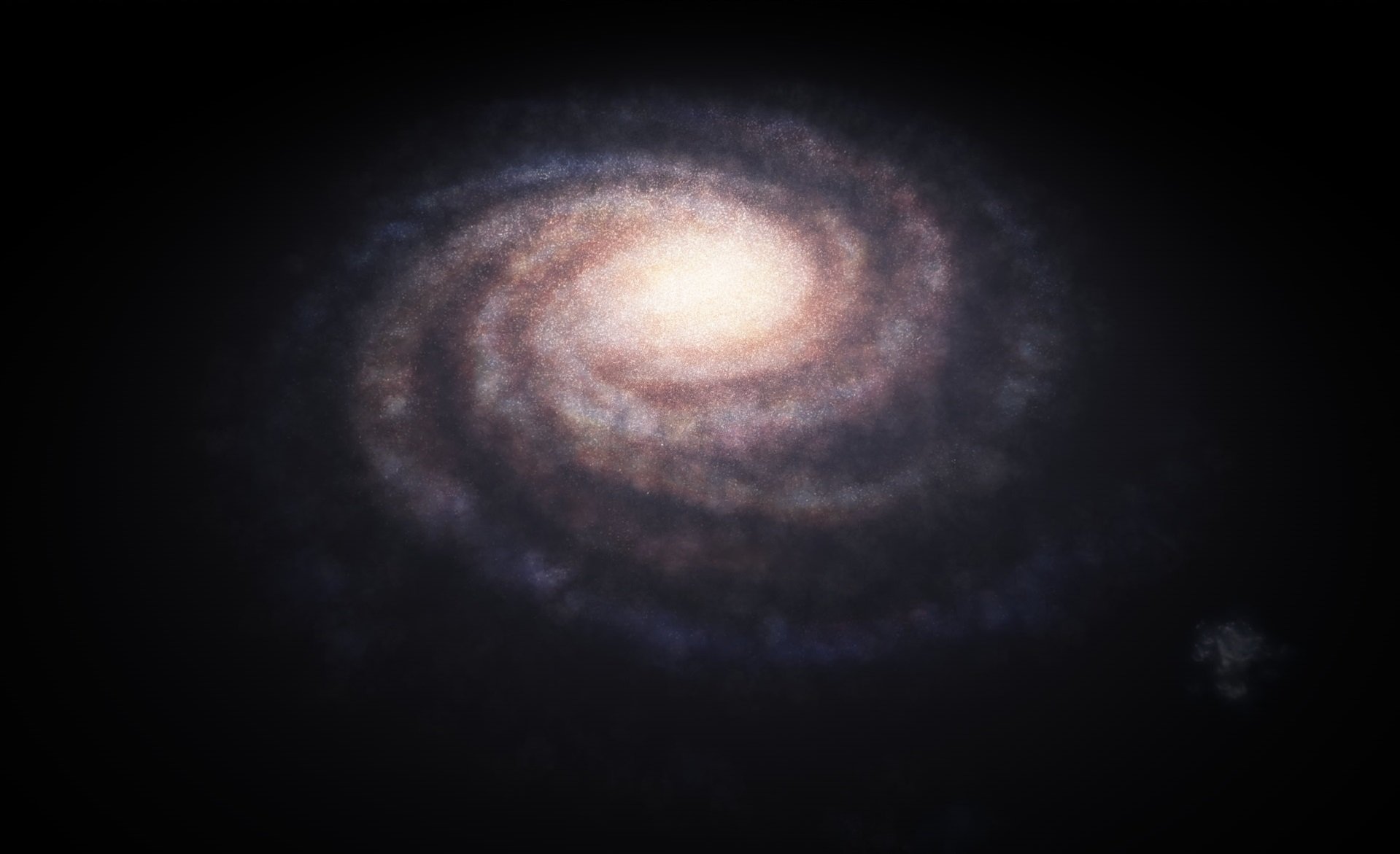Oggi non parlerò specificamente di MMO. Qualche tempo fa ho letto un articolo di Wired che spiegava come giocare ai titoli open world, mai così numerosi come negli ultimi anni, influenzi il nostro modo di intendere (e giocare) i videogame. Dal momento che l’articolo rappresenta un’opinione personale dell’autore, com’è naturale, ci sono cose su cui son d’accordo e altre su cui non lo sono, motivo per cui ho deciso di parlare del tema con un pezzo mio.
Oggi cercheremo di scoprire se, come direbbe Shakespeare, i giochi open world sono fatti della stessa materia di cui sono fatti i sogni. Sono comunque consapevole del fatto che la materia trattata è estremamente complessa e variegata. Questo speciale, in altre parole, non ha pretese di esaustività, ma se anche solo riuscirò a fornirvi degli spunti di riflessione interessanti potrò ritenermi soddisfatto.
Innanzitutto, che cosa s’intende con open world? A questa domanda è piuttosto semplice rispondere: come dice la parola stessa i videogiochi open world sono giochi “a mondo aperto”, ovvero un gioco in cui l’utente può muoversi liberamente all’interno di un mondo virtuale, spesso senza schermate di caricamento.
I titoli open world sono stati senza dubbio un passo importante nello sviluppo del nostro medium preferito. Oggi è facile darli per scontato, ma c’è stato un periodo in cui anche solo pensare a un gioco senza caricamenti tra una zona e l’altra aveva un che di rivoluzionario. I primi (neanche tanto timidi) tentativi si possono far risalire agli anni Ottanta: ne è un esempio Elite, il simulatore spaziale di David Braben che riproduceva davanti agli occhi del giocatore un’intera galassia esplorabile (un po’ come fa oggi il suo seguito, Elite Dangerous, ma con una grafica che ora sembra preistorica). A settare nuovi standard produttivi e qualitativi ha però contribuito quella meravigliosa fucina di talento, libertà creativa e progresso tecnologico rappresentata dal periodo a cavallo degli anni Duemila, con giochi storici come Shenmue nel 1999 (uscito solo su Dreamcast) e Grand Theft Auto III nel 2001. In particolare quest’ultimo, con la Liberty City ispirata a New York che ha fatto da sfondo anche ad altri titoli del franchise, è stato uno dei giochi più influenti della sua generazione, portando a livelli mai visti prima il concetto di free roaming.
Qua, in realtà, si pone un dubbio spinoso e particolarmente ricorrente, ovvero la differenza tra giochi sandbox, open world e free roaming, che però non andrò ad approfondire oggi per evitare un off-topic di due pagine (arriverà il momento, non temete, con uno speciale dedicato).
Il punto di vista dei publisher…
Resta il fatto che questa è più che mai la generazione degli open world: sembra che ormai un publisher non sia nessuno se non pubblica sotto la sua egida almeno una produzione tripla A di questo tipo. A dimostrazione delle mie parole il vice presidente esecutivo di Electronic Arts Patrick Söderlund a ottobre ha dichiarato che anche EA Studios è al lavoro per ritagliarsi uno spazio nel genere degli action open world: a onor di cronaca, pare che il gioco sarà sviluppato da Motive Studios, la nuova software house diretta da Jade Raymond, programmatrice ex Ubisoft nota per aver lavorato alla serie Assassin’s Creed fin dal primo episodio. In altre parole, EA sembra voler seguire lo stesso cammino intrapreso due anni fa da Warner Bros con l’ottimo Middle-earth: Shadow of Mordor, action open world anch’esso ispirato alla saga degli assassini ma non privo di idee originali come il Nemesis System. Non solo, ma secondo le ultime indiscrezioni il titolo sviluppato da Motive Studios dovrebbe sfruttare il franchise di Star Wars. Per parafrasare Calvin Candie, se prima avevano la mia curiosità, ora hanno la mia attenzione.
Insomma, si direbbe che sviluppare giochi open world sia diventata una specie di corsa all’oro. E a ragione: i dati dimostrano che tendenzialmente un prodotto come Skyrim o Fallout 4 viene venduto sul mercato dell’usato molto meno rispetto a uno sparatutto lineare da 10 ore. I giocatori tendono inoltre ad acquistare anche i successivi DLC (o espansioni) per assicurarsi l’esperienza completa di gioco, singolarmente o in toto tramite il Season Pass.

Un open world ambientato nell’universo di Star Wars con una grafica aggiornata al 2016? Dove devo firmare?
… E quello dei giocatori
Dal punto di vista dei player, la situazione è altrettanto favorevole? Di primo acchito si direbbe di sì. Un titolo come Fallout 4 può infatti tenere impegnati per centinaia di ore, con la noia che spesso sopraggiunge soltanto dopo aver concluso la storia principale e cappato il proprio personaggio.
Prendiamo The Elder Scrolls V: Skyrim. All’uscita del gioco, nel novembre del 2011 (come passa il tempo) scrissi nella mia recensione che era un titolo capace di rinverdire i fasti della grande tradizione del gioco di ruolo occidentale. Nonostante oggi a giocare Skyrim senza mod si possano facilmente notare alcune crepe nell’impianto ruolistico e nel comparto grafico, non sono affatto pentito di averlo scritto: sì, perché tramite la visuale, i suoni, i colori, le meccaniche di gioco e la libertà esplorativa Skyrim cerca di riprodurre la ricchezza sensoriale di un’esperienza fantasy; un tentativo ovviamente non esente da critiche, ma cionondimeno affascinante.
Skyrim, in altre parole, è stato IL gioco della generazione PlayStation 3/Xbox 360, non per forza il migliore, ma sicuramente uno di quelli che più è entrato nell’immaginario collettivo: ha venduto oltre venti milioni di copie ed è uno dei titoli più moddati di sempre nonchè il capitolo più famoso della saga, al punto che la sua popolarità può diventare un problema per altri prodotti, anche dello stesso franchise. Ne è un esempio lampante The Elder Scrolls Online, MMORPG dello stesso franchise che, pur mettendo a disposizione l’intero continente di Tamriel, ha sofferto (e in parte continua a soffrire) del confronto col quinto capitolo della serie single player in termini di fascino, libertà ludica, messinscena audiovisiva e semplice immersività. Non a caso è anche stata annunciata una edizione rimasterizzata di Skyrim per PlayStation 4 e Xbox One.
Nel 2011 il prodotto Bethesda ha rappresentato la rinascita dell’epic fantasy e ha lasciato un segno indelebile così come sta facendo The Witcher 3: Wild Hunt, titolo di cui è appena uscito il secondo meraviglioso DLC, Blood and Wine, e che purtroppo non ho ancora avuto il tempo di approfondire quanto vorrei. Giochi come Skyrim e The Witcher 3 (o, risalendo a una generazione precedente, The Elder Scrolls IV: Oblivion e Gothic 3) costituiscono delle vere e proprie avventure, delle esperienze di vita alternativa in un universo virtuale, che dopo decine e decine di ore presentano ancora meraviglie inesplorate che aspettano solo di essere scoperte. E d’altronde oggi, con l’E3 ormai alle porte, è sotto gli occhi di tutti il fatto che quest’anno potremmo assistere a orizzonti inediti per “brave new worlds”, coraggiosi nuovi mondi da esplorare e colonizzare, da Mafia III a Horizon: Zero Dawn fino a Kingdom Come: Deliverance.

Nonostante bug e incertezze tecniche a profusione, il regno di Myrtana in Gothic 3 era un gran open world.
Open world fallimentari (e non)
L’open world è quindi la panacea di tutti i mali? Ovviamente no. Innanzitutto un open world deve essere costruito con criterio, senza ricorrere a strumenti che alzino artificiosamente la longevità: ne sono un esempio l’abuso di collezionabili, achievement e tutti quegli eventi e fetch quest che sembrano pensati solo per riempire un mondo che altrimenti risulterebbe vuoto. Che poi intendiamoci, non c’è nulla di male a creare un open world relativamente vuoto se gli sviluppatori danno ai giocatori gli strumenti per riempirlo. Peccato che spesso si preferisca saturare un mondo virtuale di riempitivi in modo compulsivo, per evitare che gli utenti possano sentirsi smarriti o senza “cose da fare” anche solo per un minuto. L’horror vacui dei videogame? Forse, ma a questo tema dedicherò un altro speciale.
Se a vincere il premio degli open world che falliscono nel tentativo di offrire contenuti avvincenti è Sacred 2: Fallen Angel del 2008, con le sue centinaia di quest da fattorino, ci sono poi dei titoli tripla A che presentano degli open world semplicemente inutili: è il caso di Watch Dogs, che può anche essere un buon action game ma offre un open world mediocre, privo di quella coerenza e credibilità necessarie per superare la prova del tempo e diventare un classico. Il mondo di Watch Dogs scimmiotta quello di Grand Theft Auto V senza riuscire ad eguagliare in profondità il capolavoro Rockstar. Il problema principale è causato dal comparto tecnico e, più in particolare, da una pessima simulazione fisica: ne sono un esempio i frequenti muri invisibili, la povera interazione ambientale e i riflessi sui vetri che non corrispondono a ciò che dovrebbe esser riflesso, per non parlare dei famosi idranti la cui acqua compenetra con le automobili (come documentato da questo cliccatissimo video). Tutto ciò è sintomo di gravi errori di programmazione e di un’ottimizzazione carente.
In questo senso la campagna pubblicitaria di Ubisoft che invitava i giocatori a comprare Watch Dogs per vederne la rappresentazione digitale di Chicago, dicendo che “due mesi sono sufficienti per visitare Los Santos”, si è poi ritorta contro la casa francese in occasione dell’uscita di GTA V per PlayStation 4 e Xbox One, grazie alla geniale pubblicità della stessa Rockstar (che vedete qui sotto). È il karma, nonché un esempio di quel che succede a scherzare col fuoco.
Finora abbiamo dunque analizzato il punto di vista dei publisher e quello dei giocatori, portando esempi di titoli open world di successo e di altri che invece falliscono nell’offrire contenuti liberi e avvincenti, a causa di errori di design, problemi nella costruzione dell’universo di gioco o semplice pigrizia dei developer. È questo il caso di Sacred 2 o Watch Dogs, che non riescono a declinare le rispettive meccaniche e funzionalità all’interno di mondi digitali ispirati.
Quando liberi da queste limitazioni e prigioni mentali, gli sviluppatori possono invece concentrarsi sul realizzare luoghi virtuali che premino l’esplorazione in modo sottile e intelligente. Dark Souls, ad esempio, riempie il suo pur piccolo mondo di gioco con simbolismi criptici e misteriosi, che accennano a livelli di significato più profondi senza spiegarli a fondo. Grazie all’uso della narrazione ambientale, in Dark Souls anche solo un evocativo indizio sul lore o la descrizione di un oggetto può arricchire l’esperienza del giocatore più attento.
Praise the open world
D’altra parte in Dark Souls sembra di stare all’interno di un piccolo open world, cosa in realtà non del tutto vera dato che, a parte alcune zone, gran parte del mondo di Lordran è costituita da stanze e corridoi interconnessi. In questo senso Dark Souls è simile a un altro gioco di culto, Deus Ex (nonostante quest’ultimo presenti una progressione temporale che l’altro non ha), perchè entrambi presentano livelli abbastanza aperti atti a dare una sensazione di libertà di movimento, ma senza sconfinare nell’open world fatto e finito. Oltretutto il primo Dark Souls va lodato per il suo level design esteso anche in verticale, che contribuisce a dare quel “vibe” da ambiente aperto. Però la differenza sostanziale con i veri open world sta nel fatto che, nonostante la sensazione di essere liberi, le mappe sono comunque ridotte e non permettono la libertà di movimento omnidirezionale di un TES/GTA a caso.
A voler ben vedere, la differenza tra un Dark Souls e un vero open world è tutta in un termine: se nel primo caso si parla di mappa di gioco, nel secondo parliamo di ambiente inteso come “contenitore”, parafrasando la definizione di mondo virtuale data da Richard Bartle in Designing Virtual Worlds: il teorico inglese, padre spirituale dei MUD, ha infatti definito un mondo virtuale “a virtual environment that its inhabitants regard as being self-contained” (“un ambiente virtuale i cui abitanti si considerano autosufficienti”). La differenza tra i due tipi di struttura ludica è insomma fotografata da questa diversa nomenclatura, mappa e ambiente, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Dark Souls dà al giocatore la sensazione di trovarsi in un open world, ma molti percorsi sono in realtà lineari.
Così come nasconde i suoi segreti al giocatore, Dark Souls occulta anche i caricamenti: se non si usa il teletrasporto tramite i falò, infatti, in gioco non si vedono mai loading screen. In realtà i caricamenti ci sono ma vengono intelligentemente celati da espedienti anch’essi carichi di simbolismi, tra ascensori e lunghi corridoi che collegano le varie zone del mondo di Lordran e fungono come “rituale di passaggio”. La brillantezza dell’opera di Miyazaki, insomma, sta nel trasformare quella che è una limitazione tecnologica in un oggetto pregno di un significato semiotico per l’universo narrativo di gioco, ponendolo sotto una nuova luce.
Pur senza arrivare a questo livello di simbolismo, quella dei caricamenti invisibili è una soluzione interessante e sperimentata anche da altri RPG, come Fallout 4. Qui quando si entra in un dungeon, o comunque un interno, i caricamenti sono spesso mascherati come sezioni giocabili sotto forma di ascensori e montacarichi: al posto di presentare un loading screen passivo, il gioco permette al PG di muoversi nel limitato spazio dell’ascensore mentre sta in realtà caricando il resto del livello. Una soluzione efficace, che ci fa tornare di prepotenza sui chiaccheratissimi prodotti Bethesda.
Qualcuno su Reddit, non senza un pizzico di malizia, definisce infatti i mondi virtuali dei titoli Bethesda (in particolare di Skyrim e Fallout 4) dei “level selection screen”, nella misura in cui la natura open world di questi giochi non è realmente integrata nel gameplay: che sia per trovare un oggetto, uccidere un NPC ostile o parlare con un alleato, quasi ogni quest o missione richiede di entrare in un interno per essere completata, sacrificando così la componente a cielo aperto. L’open world insomma servirebbe per “smistare” il giocatore verso la prossima istanza; il mondo virtuale, nonostante la sua grandezza, rimarrebbe quindi paradossalmente confinato e perciò fine a se stesso.
Ora, per quanto questa ipotesi possa sembrare un po’ esagerata, c’è sicuramente un fondo di verità nell’affermare che negli ultimi titoli Bethesda si registri una certa perdita di elementi ruolistici, la quale tende a togliere importanza alla parte più esplorativa del gioco a favore di lunghe fasi di combattimento nei dungeon. D’altra parte sono lontani i tempi di Daggerfall, col suo immenso mondo virtuale paragonabile per estensione all’Inghilterra del Sud, e altrettanto distanti sono anche le terre aliene di Vvardenfell, l’isola di Morrowind, di cui l’omonima espansione di Elder Scrolls Online, uscita a 15 anni dall’originale, non è riuscita minimamente a catturare la magia.
Non a caso tantissimi giocatori stanno aspettando con attesa spasmodica l’uscita di Skywind, total conversion di Morrowind realizzata col motore di Skyrim che promette di riportare l’open world al centro del palcoscenico. Che si stesse meglio quando si stava peggio? Forse sì e forse no, ma si tratta sicuramente di uno spunto di riflessione su cui riflettere.
Insomma, sono ormai in molti a chiedere a Bethesda un cambio di rotta, soprattutto dopo il controverso Fallout 4. Molti infatti sostengono che l’ultima fatica della software house americana sia un titolo sopravvalutato, in virtù di un comparto tecnico solo discreto e, in fin dei conti, piuttosto deludente. Entrare nel merito di questa tesi oggi mi porterebbe fuori tema: tuttavia, quel che voglio sottolineare è che la natura open world di un gioco non influisce soltanto sull’aspetto meramente tecnico. Non sto insomma parlando di quanto texture ed effetti siano graficamente stupefacenti, quanto piuttosto della presenza o meno di caricamenti, che se eccessiva può portare a una sensazione di straniamento e scarsa autenticità, il che può a sua volta causare una mancanza di empatia tra il giocatore e l’avatar controllato.
If you love something, set it free
Il caricamento non solo spezza l’azione ma mostra in modo palese tutti i limiti della tecnologia, chiedendo al giocatore di sospendere l’incredulità almeno fino alla conclusione del suddetto loading screen. Gli open world dovrebbero invece abbattere i confini, letteralmente e metaforicamente. Non è soltanto una mera questione di non dover attendere i proverbiali 30 secondi: con un open world si guadagna la sensazione che tutto l’ambiente faccia parte di un unico mondo organico, un ecosistema in cui ogni elemento è interdipendente dall’altro. A beneficiarne sono cioè la continuità e l’immersività dell’esperienza, quelle sensazioni che fanno perdere la cognizione del tempo e portano a fare le 4 del mattino quando si pensava di giocare “solo un’oretta”.
Certo è che non tutti i videogame open world lo sono alla stessa maniera. Skyrim e Fallout 4, d’altronde, sono sì giochi open world, ma come abbiamo visto presentano diversi caricamenti all’interno del mondo virtuale: la transizione tra interni ed esterni infatti non è “seamless”, ovvero senza soluzione di continuità. Lo stesso The Witcher 3: Wild Hunt non presenta un open world totale, dal momento che la mappa è divisa in tre vaste macro-aree liberamente esplorabili (Velen, Novigrad e le Isole Skellige) più una piccola area iniziale. Ciò non toglie che il mondo dello Strigo sia per qualità e immersività un eccezionale esempio di come produrre un open world “fatto a mano” (ossia non prodotto proceduralmente da qualche algoritmo), persino migliorato dai due clamorosi DLC Hearts of Stone e Blood and Wine (contenutisticamente paragonabili a vere e proprie espansioni).
C’è inoltre il già citato istanziamento invisibile, che si verifica in tutti quei giochi in cui l’open world è suddiviso in nodi, e ogni volta che si entra in un nuovo nodo (rappresentato solitamente da una regione) l’hard disk carica le informazioni per alcuni secondi, durante i quali è possibile sperimentare rallentamenti e lag del PG. Una soluzione molto usata fin dai tempi del già citato Morrowind e che ha attecchito anche in campo MMO, da World of Warcraft a Mortal Online (non senza freeze e problemi tecnici nell’ultimo caso).
Insomma, potremmo dire che c’è un grado di “quanto i giochi sono open world”. Se dovessi fare una classifica in questo senso, i titoli più notevoli che mi vengono in mente sono Arma 3, il rigoroso simulatore militare di Bohemia Interactive, e Gothic 3, il sottovalutato RPG fantasy sviluppato dai Piranha Bytes prima che perdessero la bussola con la serie Risen (mentre il loro nuovo progetto, ELEX, è un’incognita tutta da verificare). Detto questo, ad ogni cosa bisogna dare la giusta importanza: se è vero che un mondo di gioco unitario rappresenta un grande traguardo, è anche vero che per la buona riuscita di un videogame, e in particolare di un GdR, bisogna considerare prima elementi come il gameplay, la narrativa, la qualità delle meccaniche e la longevità. Detto in altri termini, non me ne faccio nulla della dicitura “open world” impressa a caratteri cubitali sulla copertina se poi il gioco fa acqua da tutte le parti.
Ma d’altronde questo articolo si focalizza su un tema ben preciso, e a tal proposito non si può non parlare dei simulatori spaziali. Nel caso di giochi come Elite Dangerous, più che di open world sarebbe opportuno parlare di “open universe”, data la loro estensione superiore alla portata umana. Qui subentrano le meraviglie della creazione procedurale, capace di ricreare una galassia basata sulla Via Lattea con 400 miliardi di sistemi solari popolati di stelle, pianeti, satelliti e asteroidi perfettamente simulati. È la magia che si verifica quando da fredde righe di codice nasce la vita, seppur virtuale. Da lì a riempire questa galassia di giocatori dediti a esplorare, commerciare, contrabbandare, estrarre minerali, combattere o compiere atti di pirateria, poi, è un attimo.
A matter of life and death
A differenza degli MMORPG, che tramite la persistenza riproducono spesso mondi dinamici e in evoluzione, i giochi open world single player hanno un indubbio vantaggio, ovvero di poter essere ripresi in mano a distanza di mesi, o anche anni, senza che nulla sia cambiato: il mondo che conosciamo sarà sempre lì, pronto ad attenderci come ce lo ricordavamo. Gli universi virtuali, insomma, resistono al passaggio del tempo. Se questi mondi ci hanno davvero appassionato è anche facile legarli a un periodo della propria vita. Non so voi, ma personalmente ricordo bene il periodo della mia vita da universitario in cui giocavo a Skyrim, le situazioni e le sensazioni che vivevo in quel periodo, tant’è che mi basta riascoltare le dolci arie dei brani di Jeremy Soule per sentire un tintinnio, una vibrazione nell’animo. È come se una parte di me fosse rimasta in quel mondo: si tratta un’associazione mentale ormai indissolubile, che per me vorrà sempre significare qualcosa.
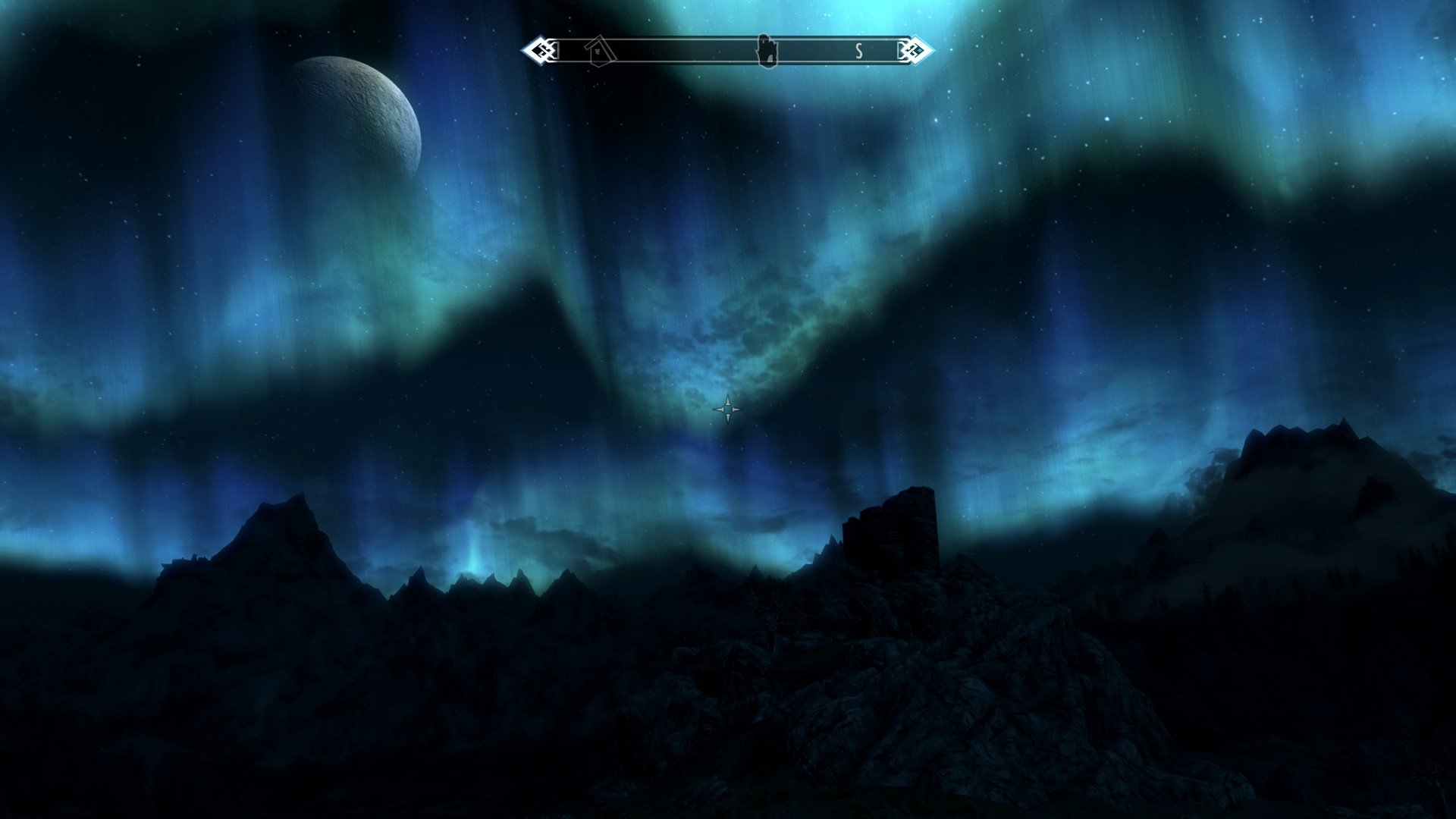
Quando l’aurora boreale spunta nella fredda notte del Nord, è difficile non innamorarsi del mondo di Skyrim.
Forse, se tendo ad associare i giochi open world a periodi particolari della mia vita è proprio perché i titoli open world sono una metafora della vita (d’altronde avete mai visto schermate di caricamento nella vita reale?). E quando avvio un gioco di questo tipo non lo faccio per spegnere il cervello ma per accenderlo in un altro modo, pensando cioè a soluzioni alternative ai problemi e immergendomi in avventure epiche lontane dal grigiore della vita quotidiana. Non importa per quanto tempo non tocchi The Witcher 3: so che la prossima volta che avvierò l’exe i Regni del Nord d’ispirazione mitteleuropea saranno lì ad attendermi, con i loro raggi di luce dorati e gli alberi mossi dalla brezza del vento. E non è forse questo l’importante?
Qui mi fermo, non prima però di aver girato la domanda a voi: qual è la vostra esperienza con i videogame open world?

Giornalista pubblicista, Plinious trova che non esista niente di più comunicativo dei videogiochi, in particolare quelli online. Da sempre appassionato di gioco di ruolo e MMORPG, ama immaginare ed esplorare mondi fantastici in cui perdersi dieci, cento, mille e una notte. La sua storia online inizia con Guild Wars Nightfall e prosegue con decine di MMO occidentali, da World of Warcraft a Warhammer Online, da Guild Wars 2 fino a Sea of Thieves.